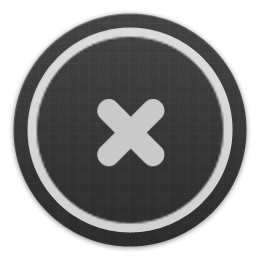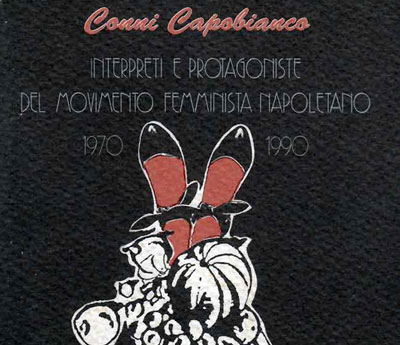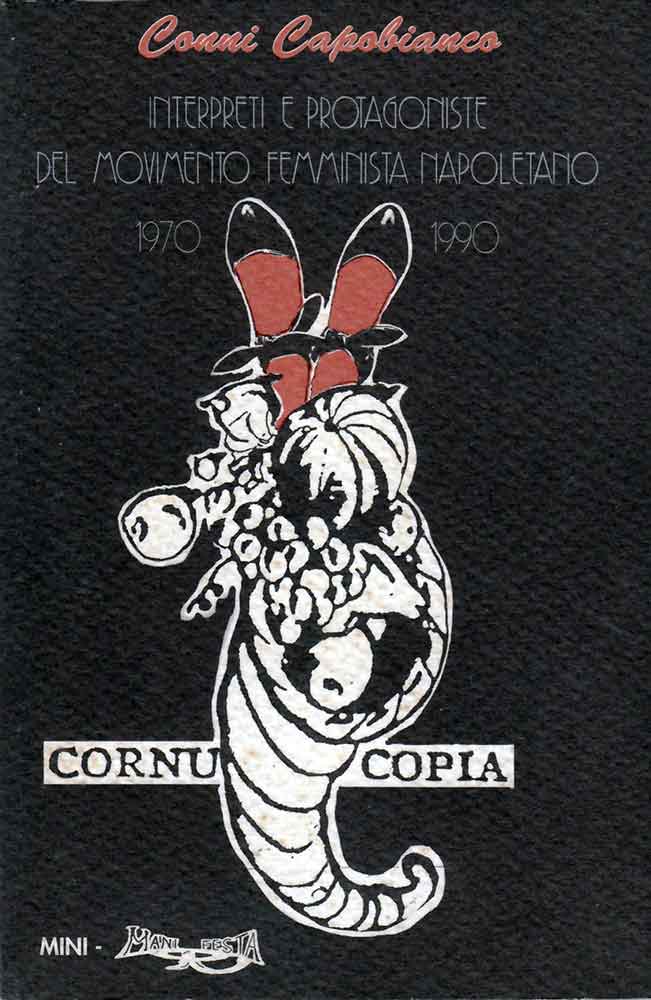Interpreti e protagoniste del Movimento femminista napoletano 1970 – 1990
di Conni Capobianco
Ediz. MiniManifesta
Napoli - 1994
Prefazione
Questo lavoro di Conni Capobianco suggerisce almeno due livelli di lettura: quello documentario e quello autobiografico: e rispetto ad entrambi ha alcuni meriti.
Negli ultimi anni abbiamo assistito a più di un tentativo, anche autorevolmente sponsorizzato, di divulgazione della tesi della fine del femminismo.
Secondo tale tesi, il, o meglio, i movimenti delle donne avrebbero fatto il loro tempo, e ammesso e non concesso anche a quel tempo una qualche funzione innovatrice
l'abbiano avuta, sarebbero ormai obsoleti nei contenuti e superati nei fatti, come dimostrerebbe, se non altro, la fine della mobilitazione delle donne a difesa dei
propri interessi di genere. Insomma, le donne avrebbero ottenuto ciò per cui si battevano, almeno nei limiti compatibili con il buon senso che deve governare
una società gestita secondo il criterio della moderazione: pertanto, le rivendicazioni delle donne avrebbero perduto la loro ragion d'essere e l'attivismo femminista
apparterrebbe ormai al passato.
Il primo merito di C.C, sta nel fatto che non sposa ma neppure confuta questa tesi sul piano ideologico o su quello politico; si impegna invece a predisporre i materiali
per quella che potremmo definire verifica fattuale. E' come se discretamente ma fermamente il libro ci dicesse:"queste eravamo e questo volevamo; guardatevi interno
e giudicate voi…".
I materiali che l’A ha raccolto riguardano il femminismo a Napoli negli anni ’70 e all'interno di esso, in modo particolare il gruppo delle Nemesiache.
….Negli anni ’70 il femminismo a Napoli era presente e vitale con molti gruppi diversamente caratterizzati…..Di questo vivace e articolato universo le Nemesiache
sono state un elemento originale e tanto vitale da essere attive ancora oggi. Percorrendo l’itinerario che C.C, traccia attraverso i documenti che propone,
alcuni caratteri del gruppo si disegnano chiari.
Mi sembra particolarmente importante la “separatezza” da loro rivendicata fin dall’inizio non come un'autoghettizzazione difensiva, quanto come condizione fondante
di autonomia e essenziale per il dispiegarsi della creatività; ma ancora più significativa (e originale nel panorama femminista italiano) mi sembra la scelta
della "produzione artistica di bellezza" come campo di lotta per la liberazione delle donne. E' un’ estetica assai radicale e assai suggestiva, quella che i documenti
testimoniano.
Si tratta ovviamente di liberarsi dei modelli maschili e, soprattutto dei ruoli imposti alle donne e legittimati da quei modelli.
Ma c’è nel progetto delle Nemesiache qualcosa di molto più radicale: il loro obiettivo non è il recupero, o magari la scoperta, di una qualche specificità femminile,
di cui, come si è detto, temono le implicazioni autoghettizzanti; il modello ideale a cui tendono è quello dell'androginia, di un mondo cioè, nel quale sia possibile
risanare la lacerazione originaria e ricomporre l’originaria opposizione, sicchè ad ognuna/o sia restituita la possibilità, l'opportunità di scegliersi, di mettersi
in giuoco, di giuocare e giuocarsi……
Il terreno elettivo, sul quale è possibile anticipare, meglio, avviare la fondazione di un mondo androgino, è, come si è già detto, quello della creazione di bellezza
in tutti i campi e gli ambiti della vita; ma il compito è per definizione riservato alle donne, le sole che per natura e cultura posseggono la capacità necessaria
a realizzarlo. Con audacia talvolta divertente talvolta suggestiva, le Nemesiache cercano tra i personaggi della mitologia mediterranea classica, le antesignane e
le precorritrici dello loro posizioni, fino a costituirsi una sorta di genealogia ideale; e indicano in Napoli e nel Golfo lo scenario che per la sua bellezza e per la
ricchezza della mitologia che lo riguarda, meglio di ogni altro luogo può ispirare e ospitare la loro azione.
Utopie? Se si esaminano i documenti presentati in questo libro, un altro dato colpisce: l’inventività, la fantasia davvero creativa con la quale questo gruppo di ragazze
riusciva in quegli anni a rendere visibili le proprie idee, a rappresentarle mettendole in pratica all'interno di situazioni sociali le più diverse,
di estrema emarginazione (i bambini del Quartieri Spagnuoli, le ‘pazze’ dell’ospedale psichiatrico del Frullone) e di culta mondanità internazionale
(la Rassegna cinematografica di Sorrento). Se utopie erano, erano socialmente accettate: che vuol dire che in quegli anni la società non solo aveva bisogno di
utopie (e quando mai non ne ha?) ma consentiva a questo bisogno di manifestarsi e di cercare e trovare un proprio appagamento. I documenti qui presentati possono
avere anche questa funzione, a mio avviso tutt’altro che secondaria: essere un contributo alla costruzione di un archivio per la memoria collettiva,
contro le semplificazioni e le schematizzazioni liquidatorie divenute di moda negli anni più recenti.
Ma possiamo essere grate, come lettrici, ad una Autrice che ci aiuta a ricordare che tra fuga in avanti e regressione rinunciataria esiste pur sempre almeno una
terza modalità: quella dell’immaginazione progettuale.
Amalia Signorelli
Rassegna
Non disponibile