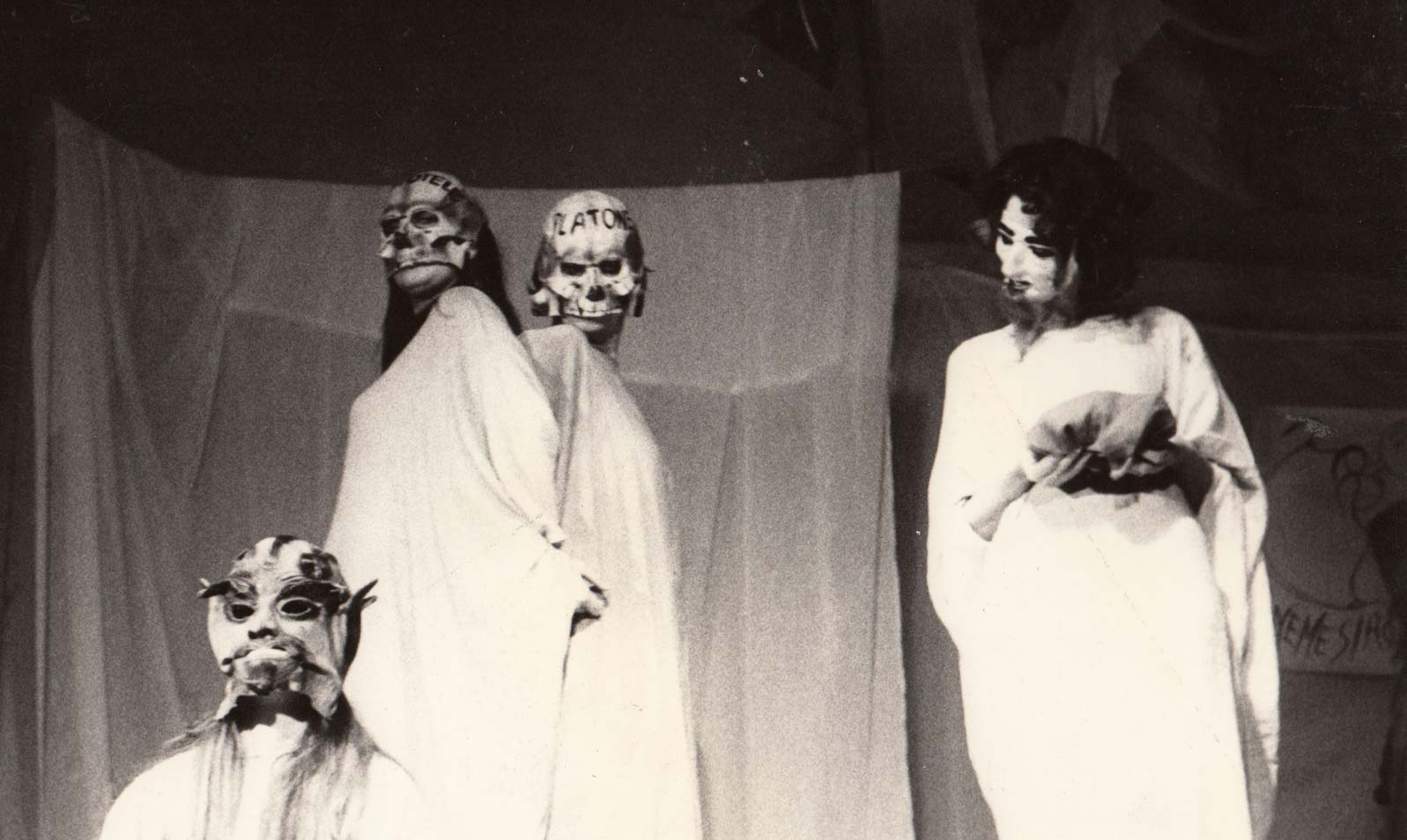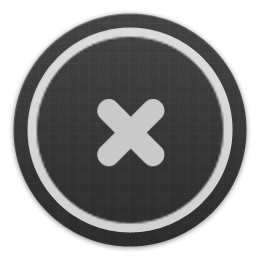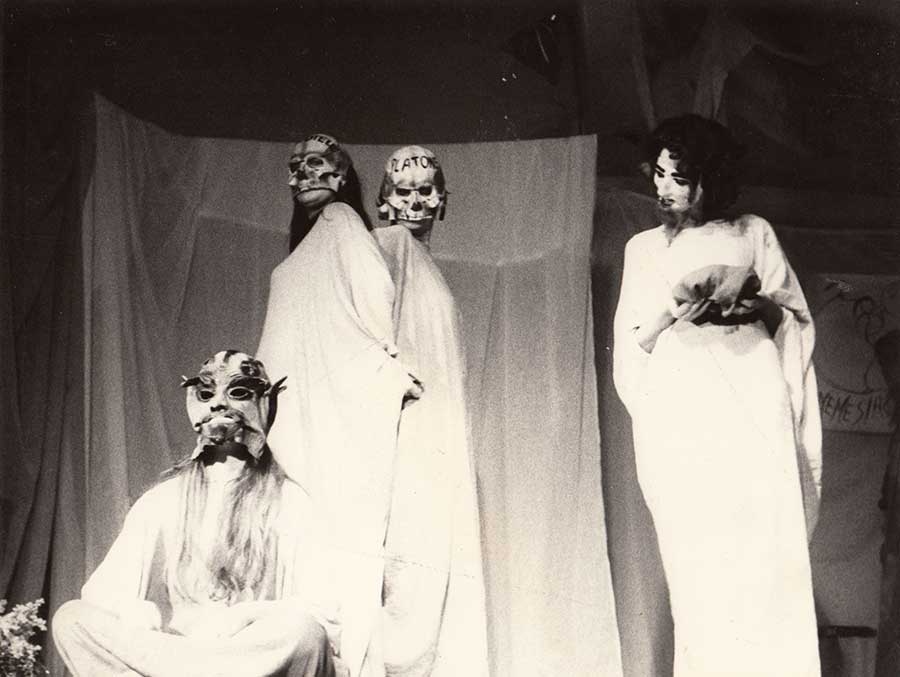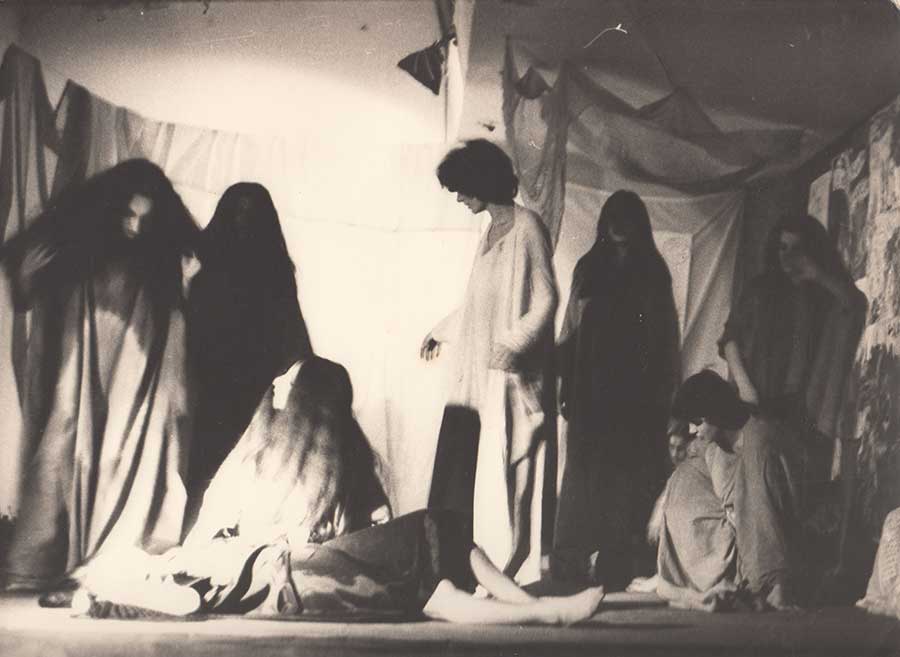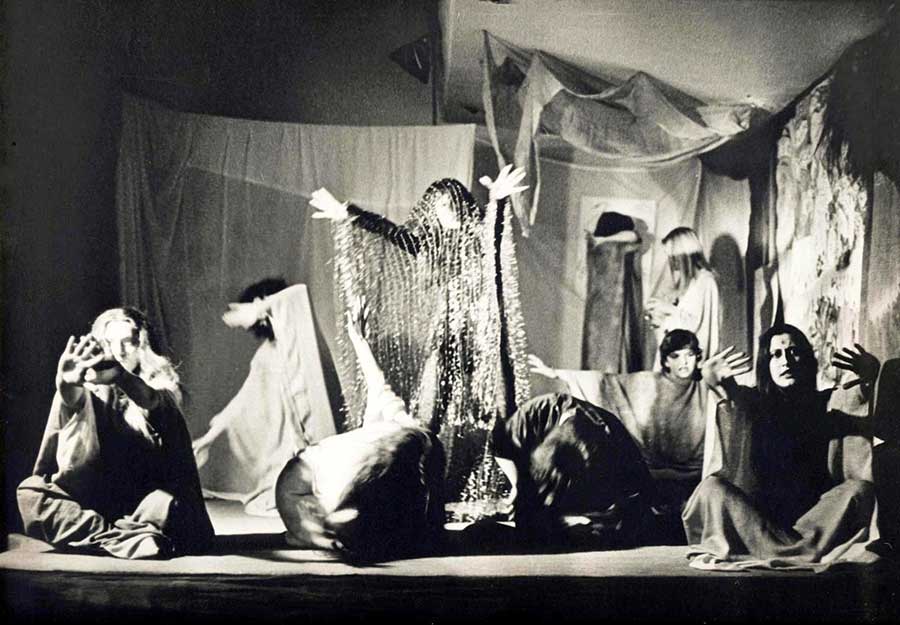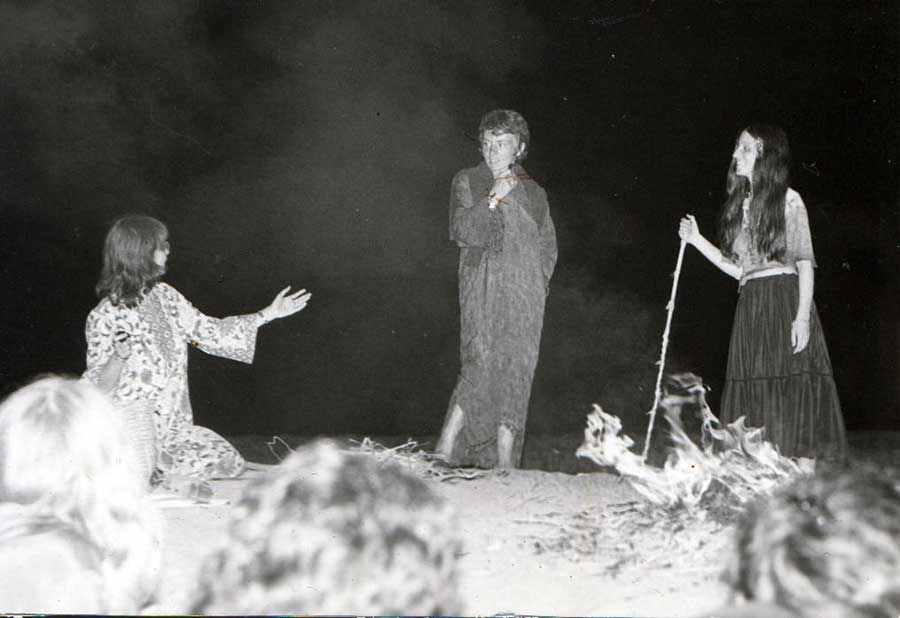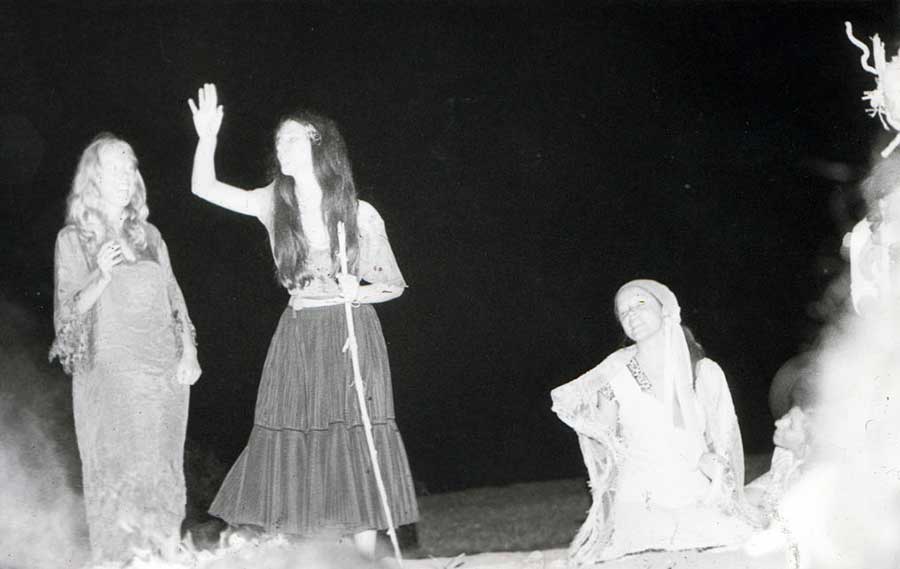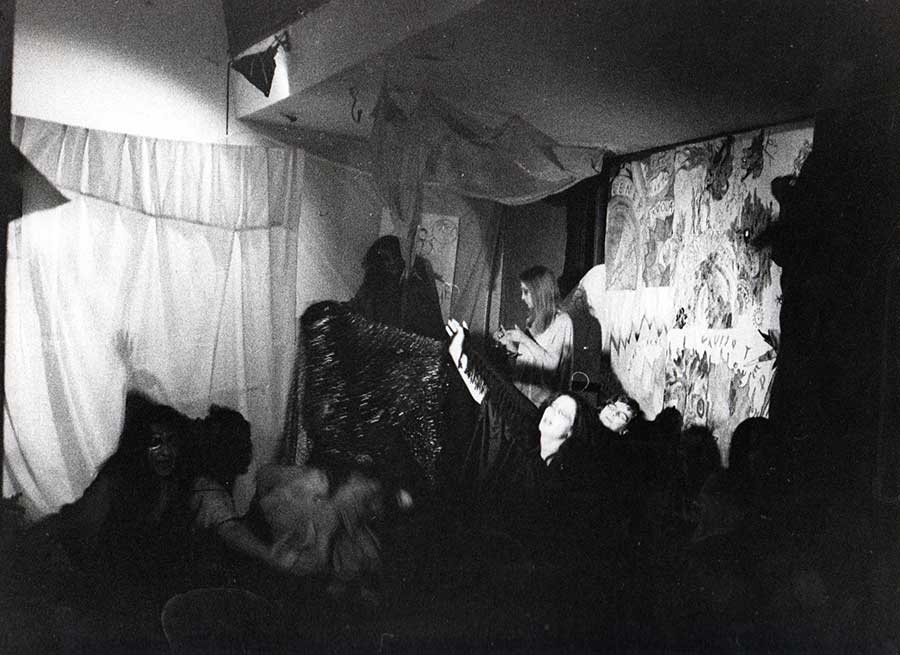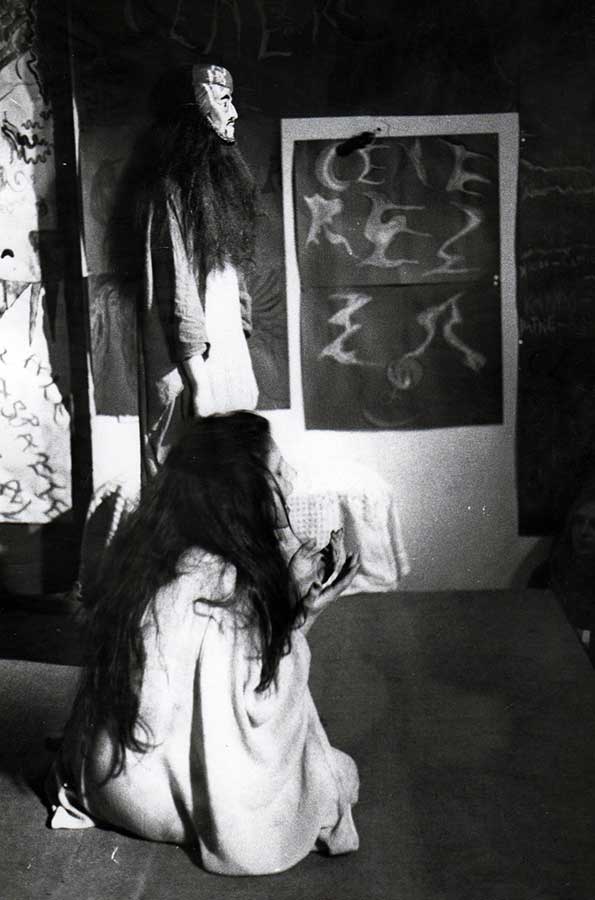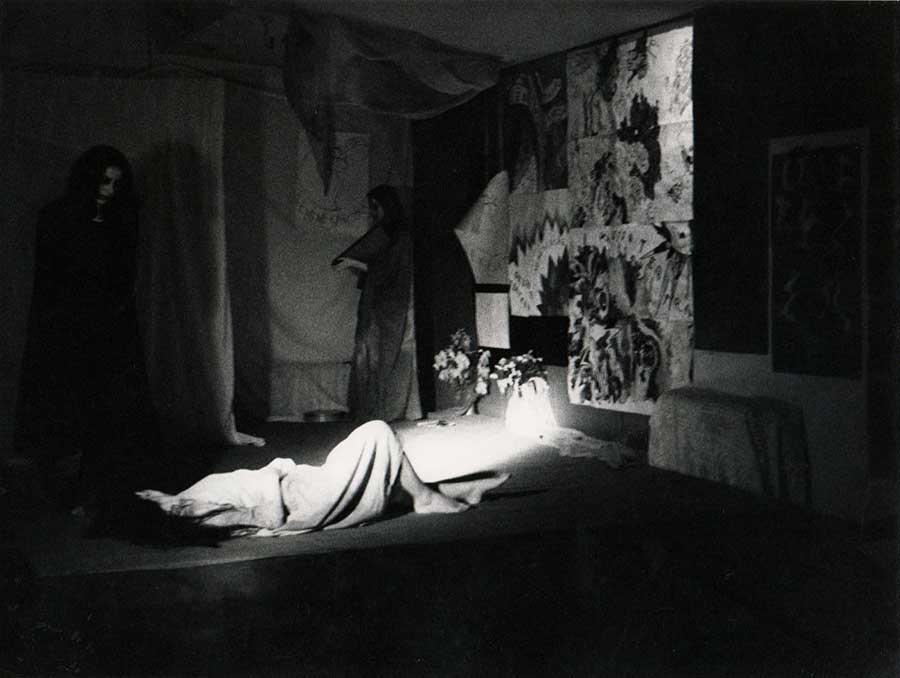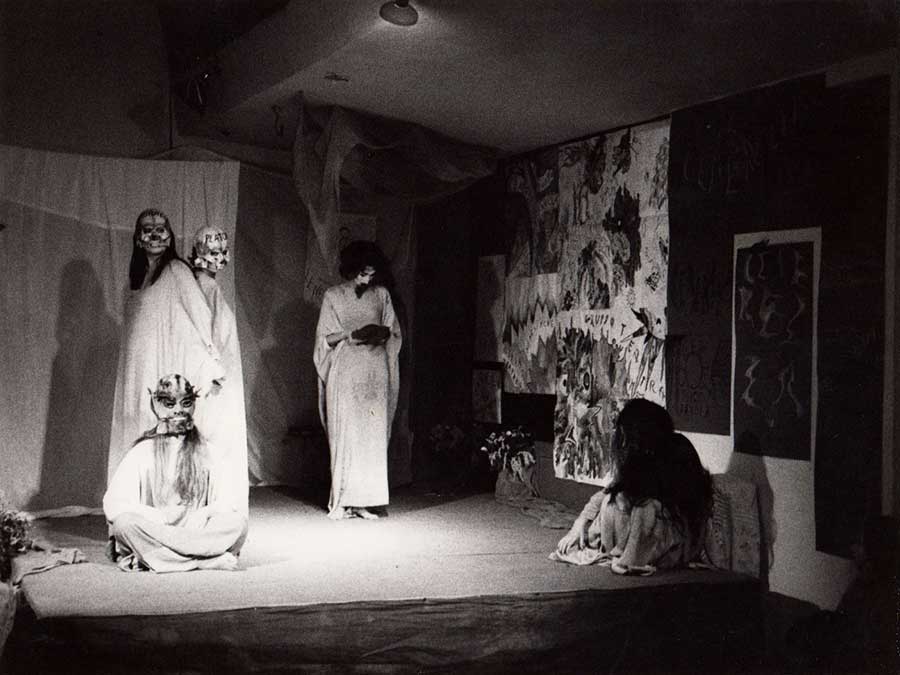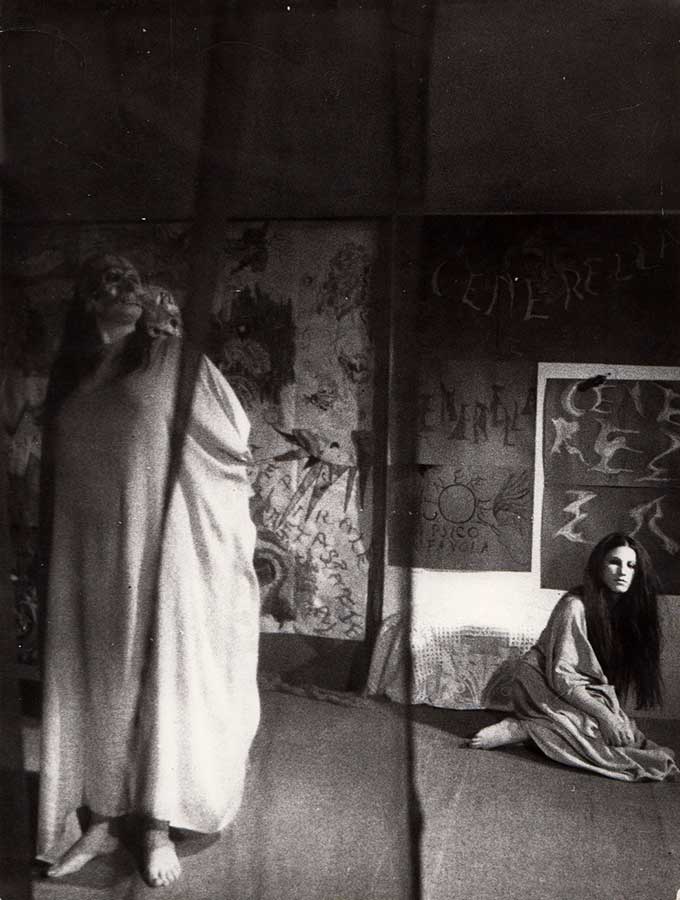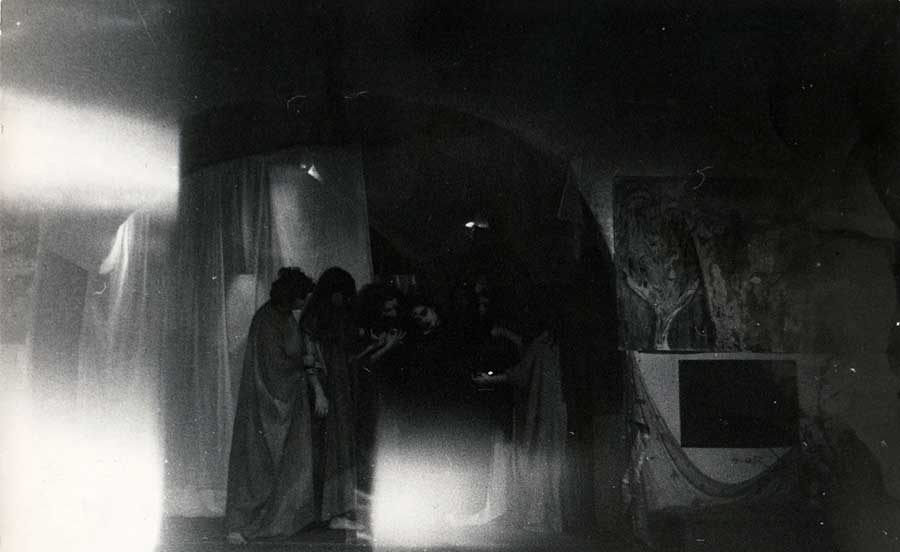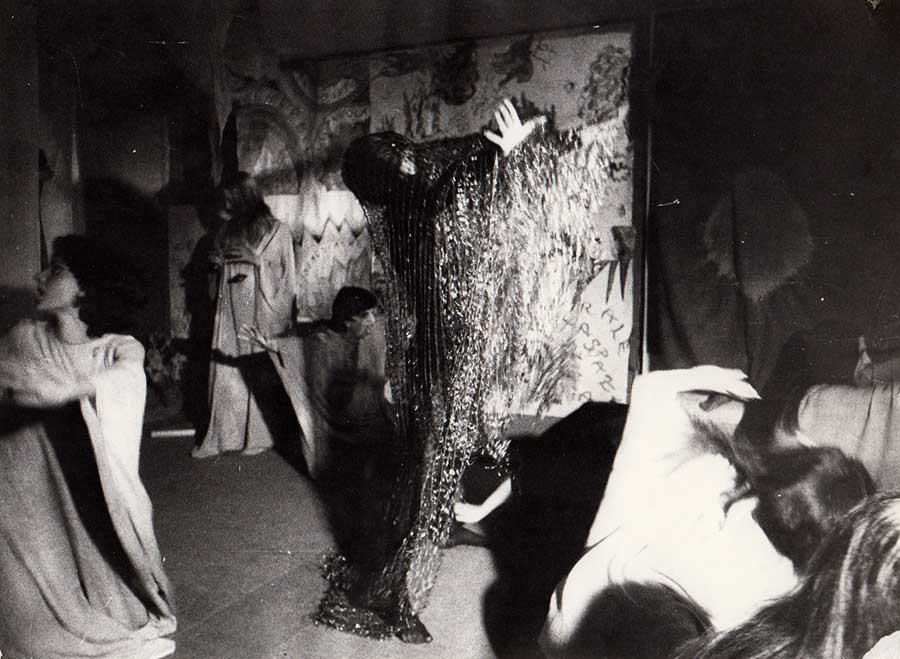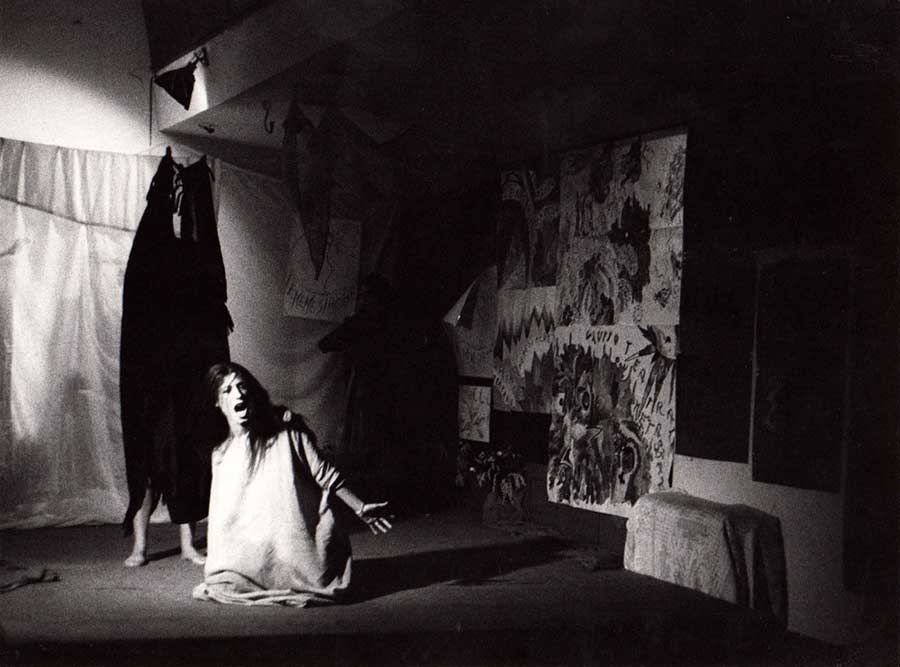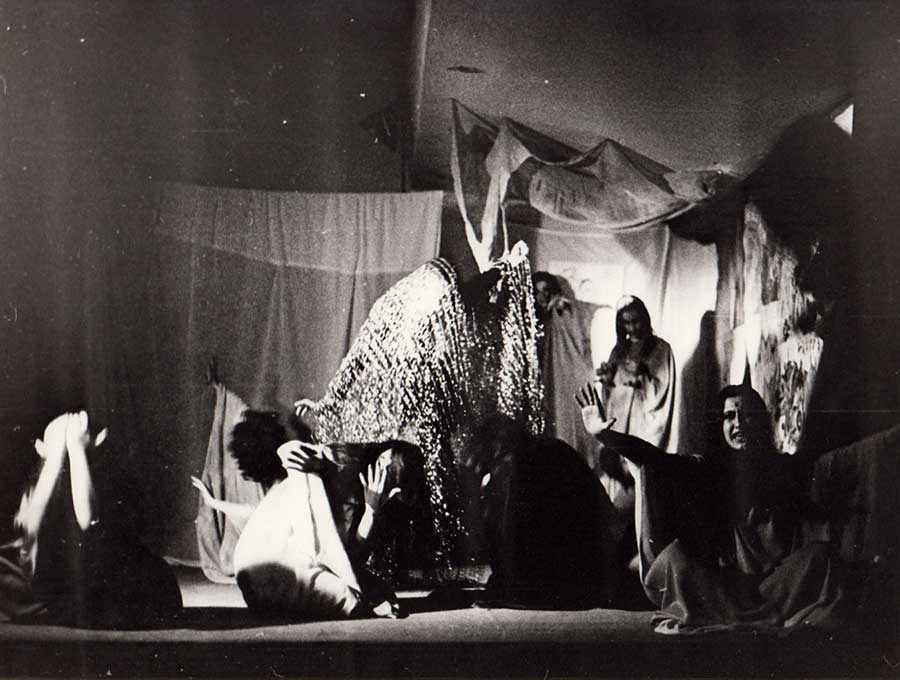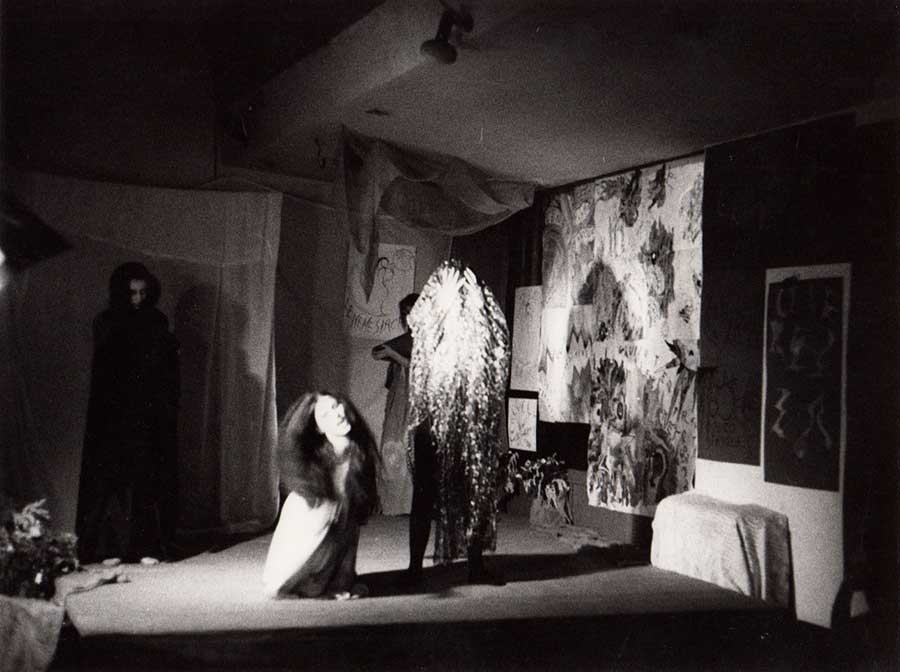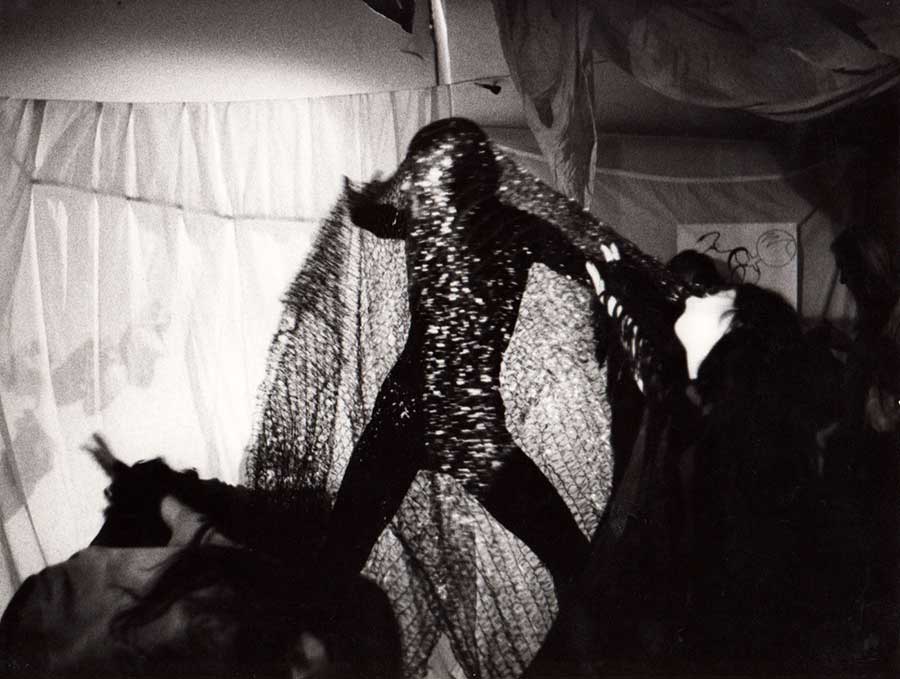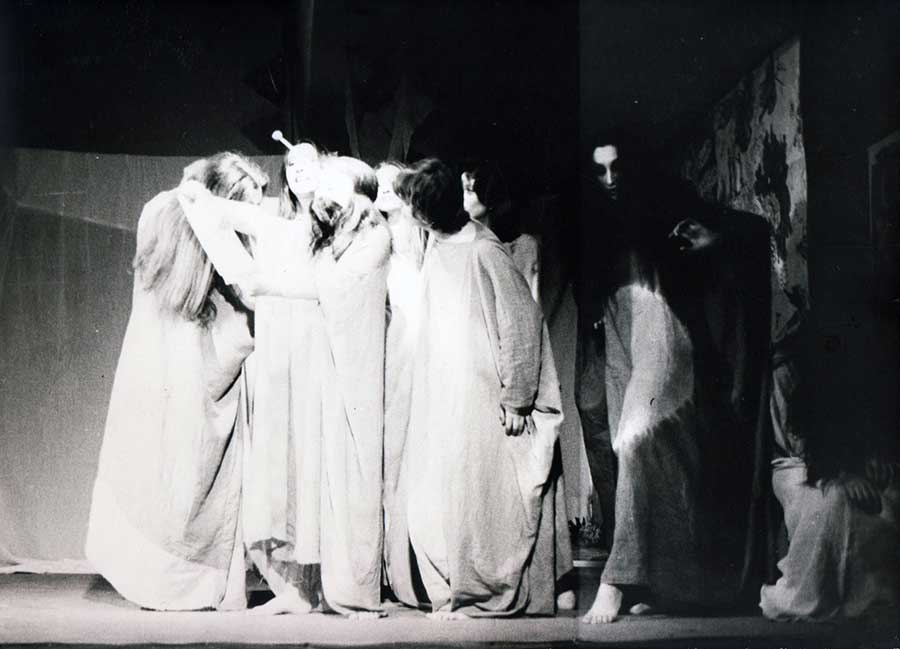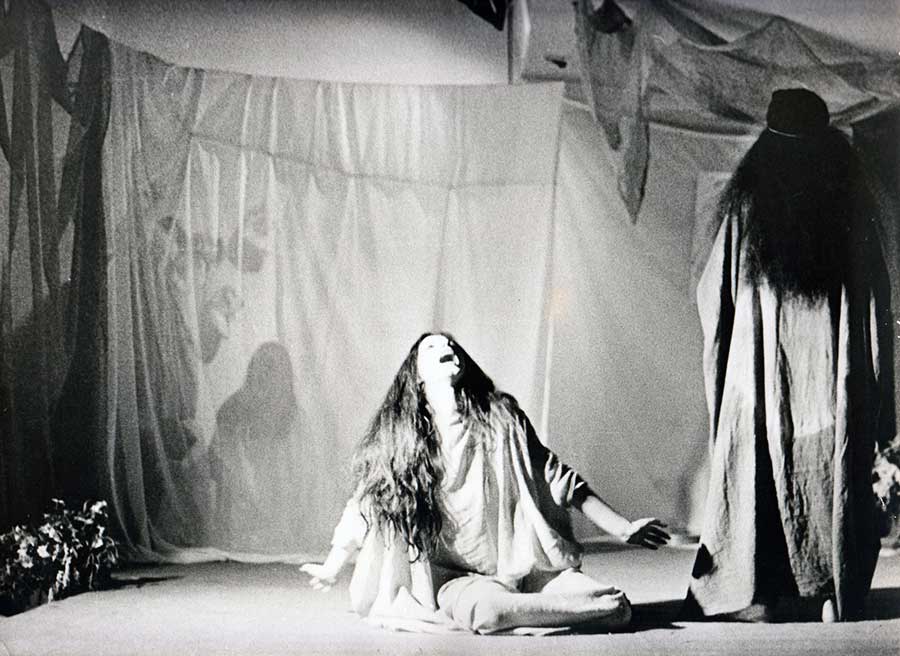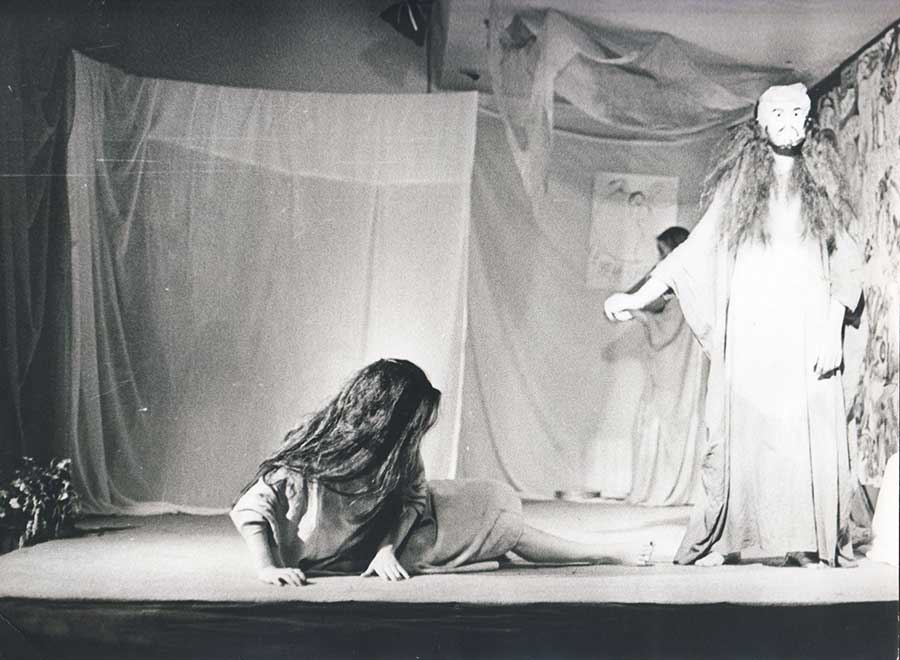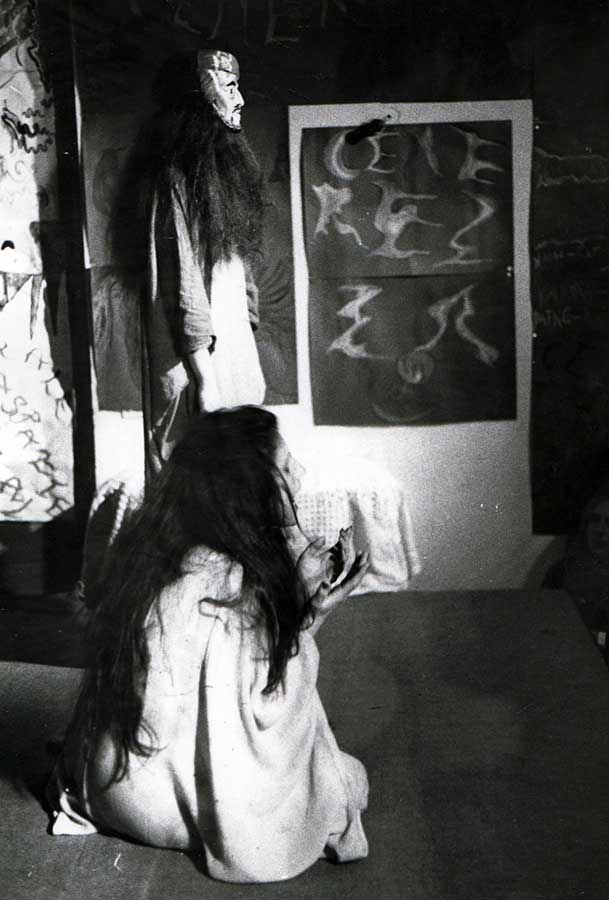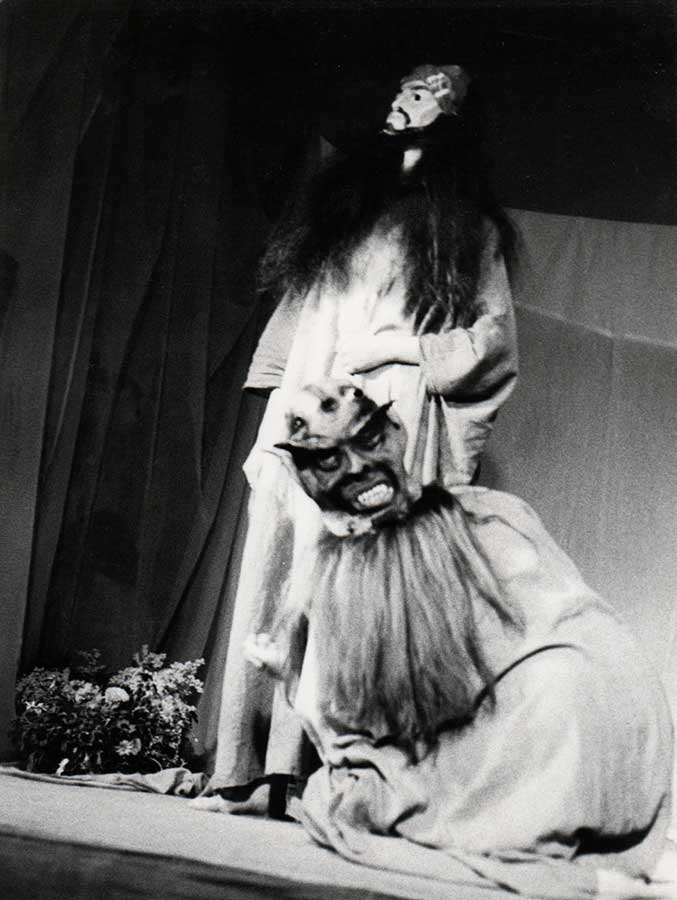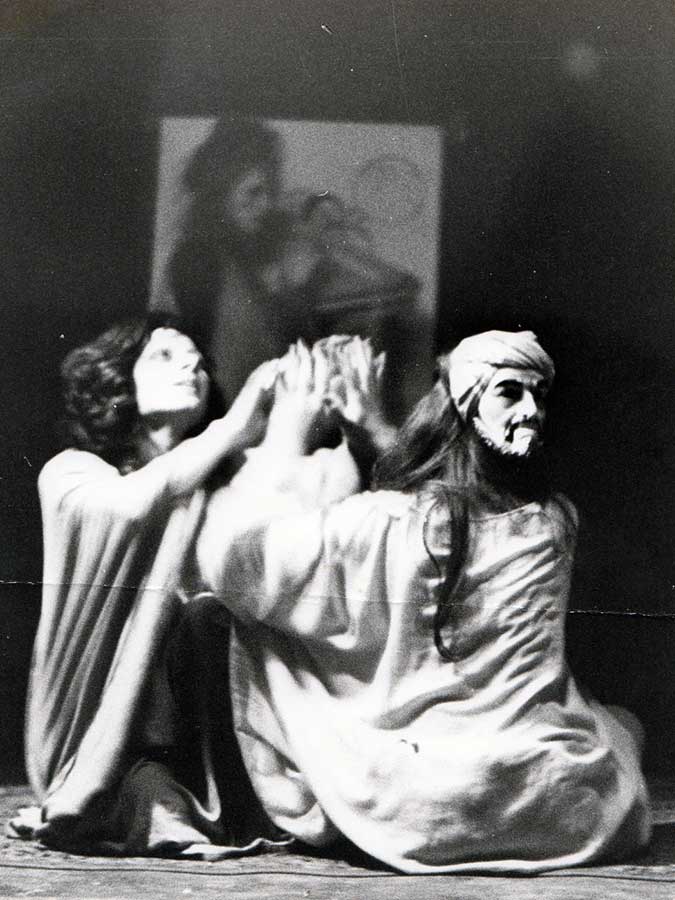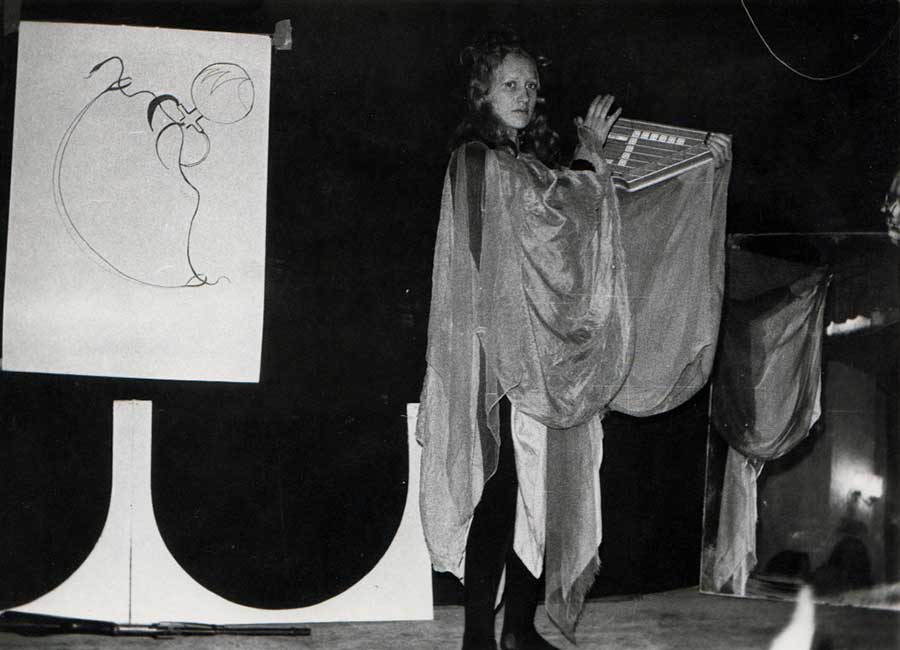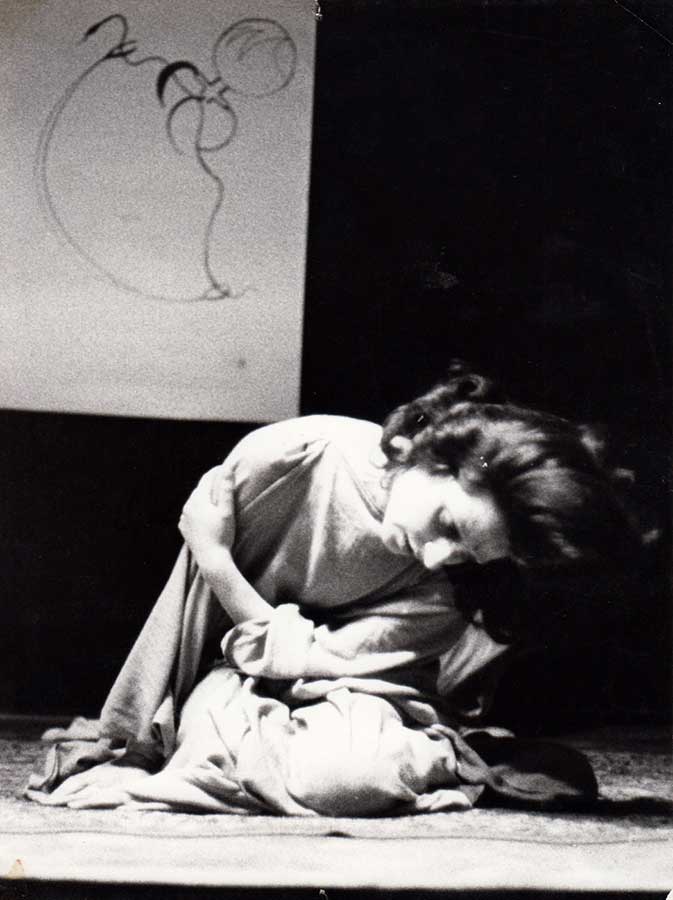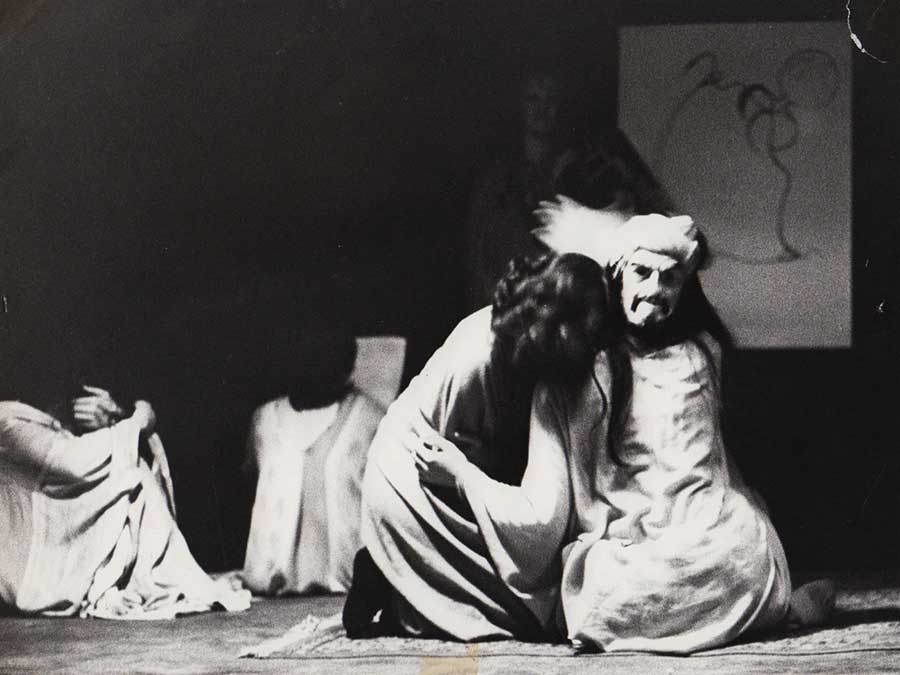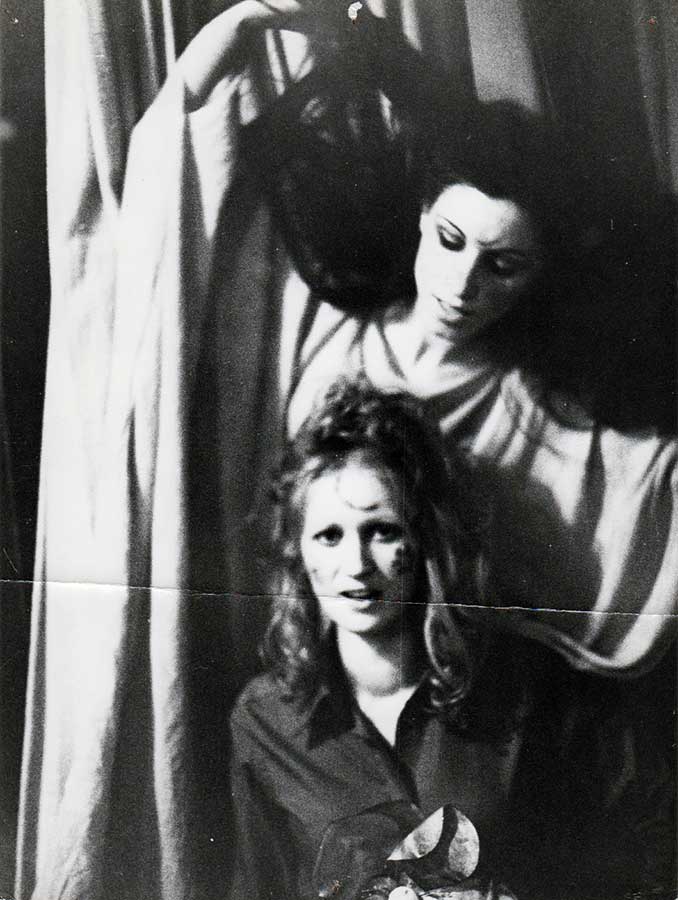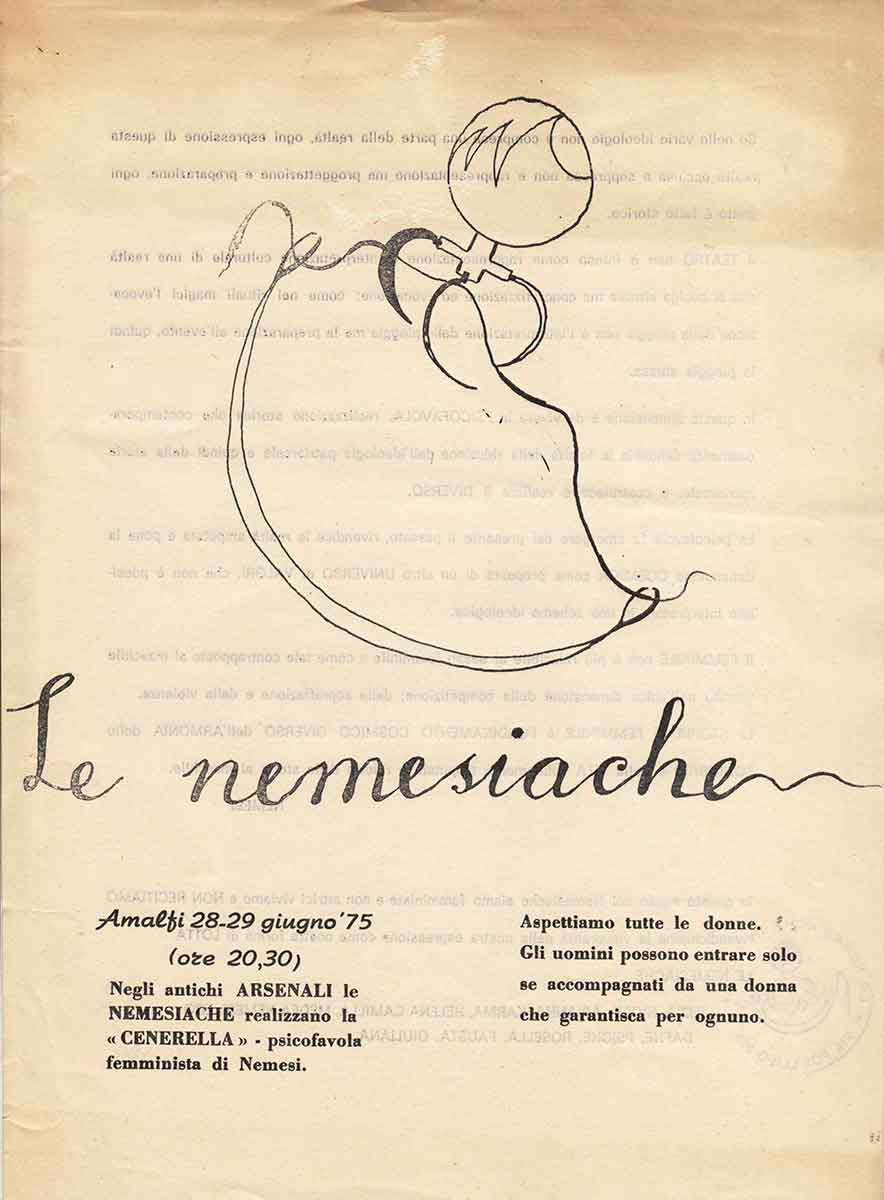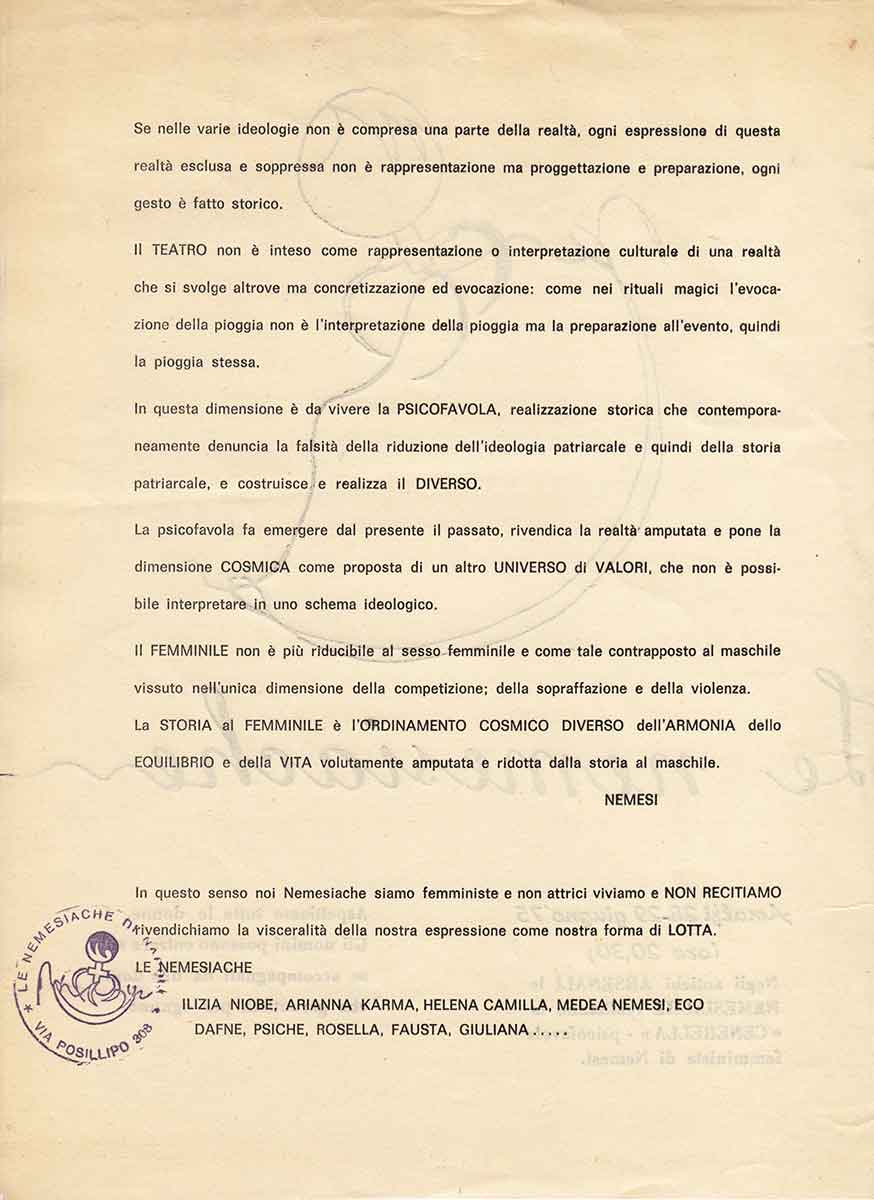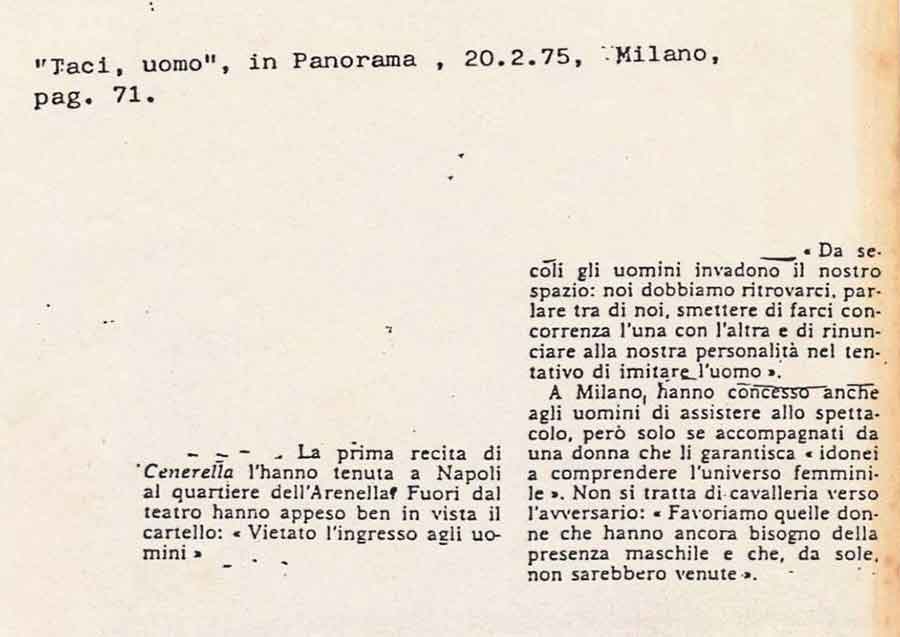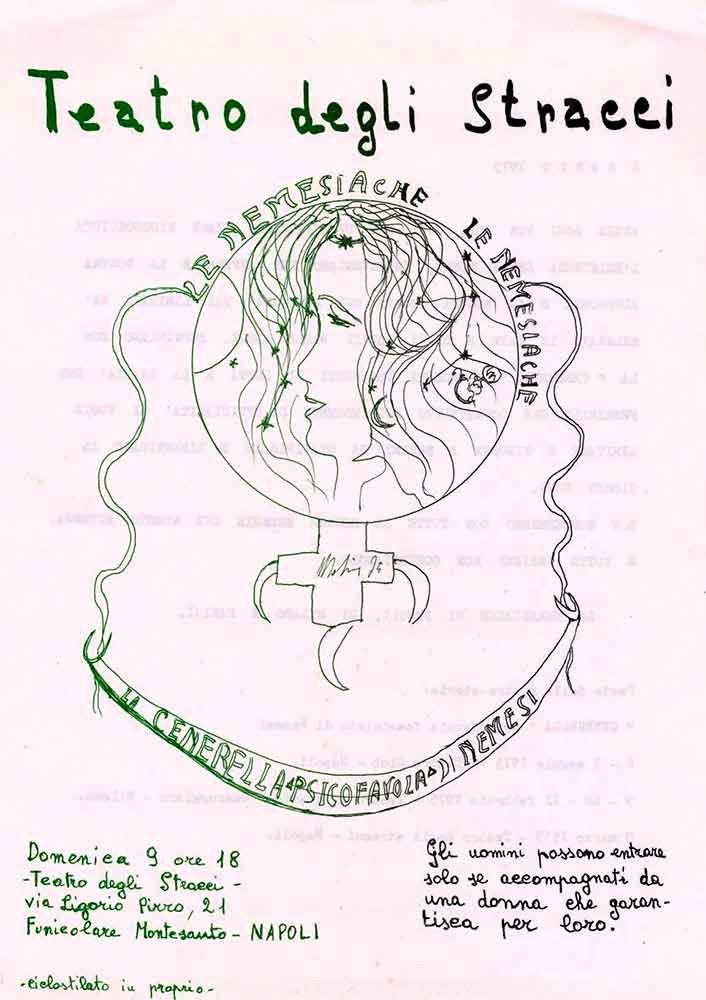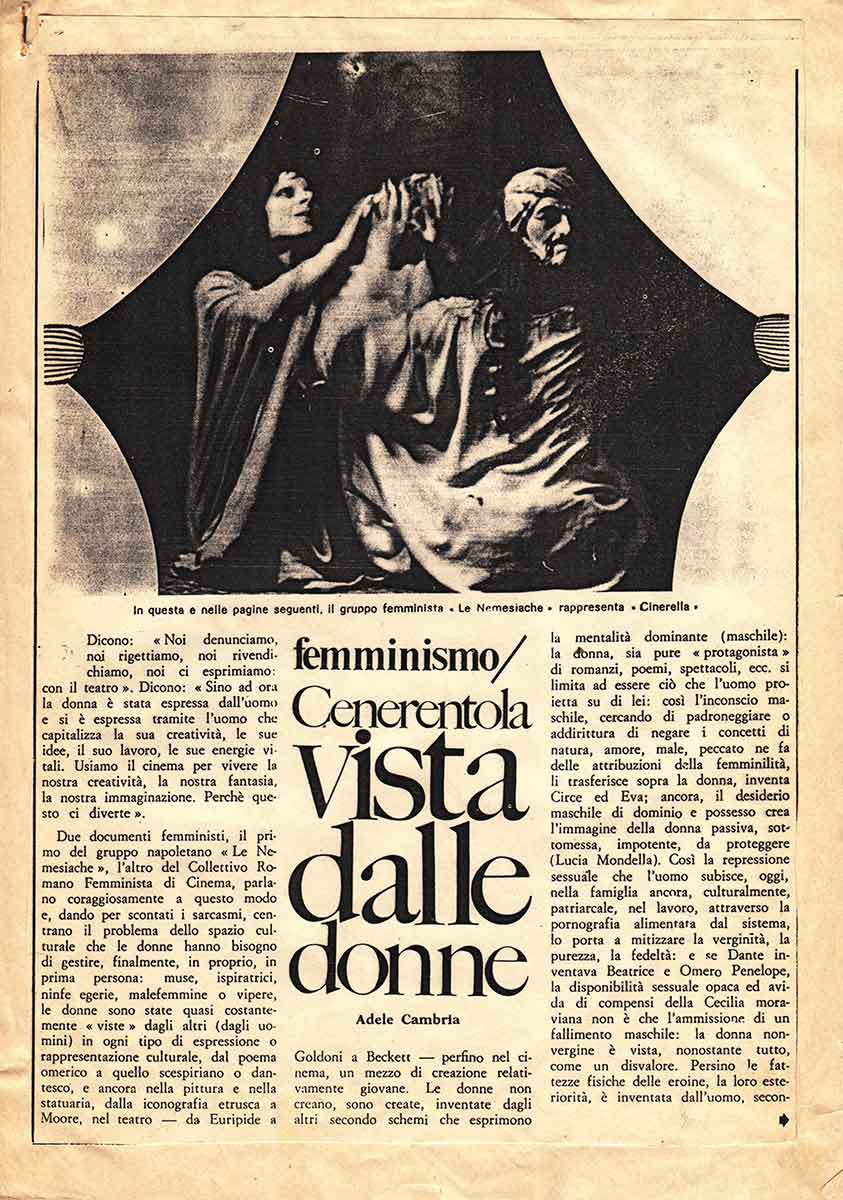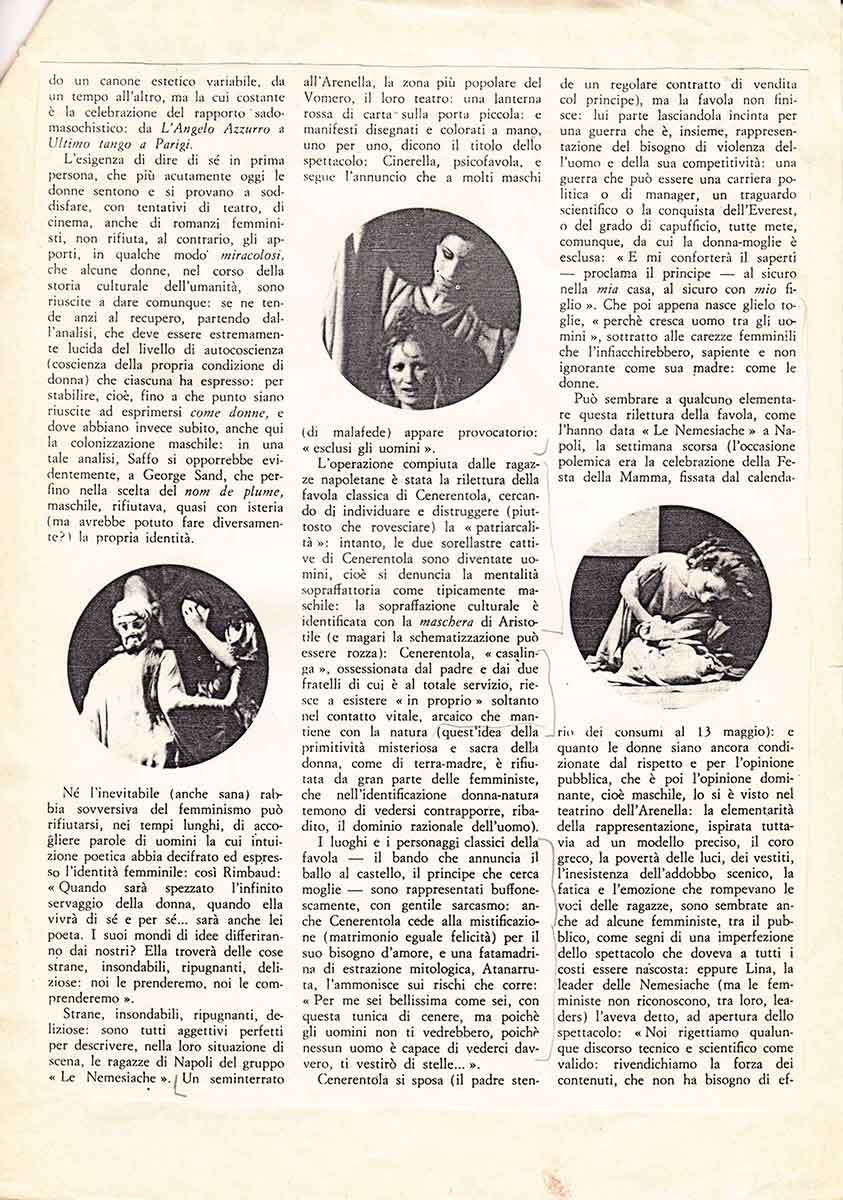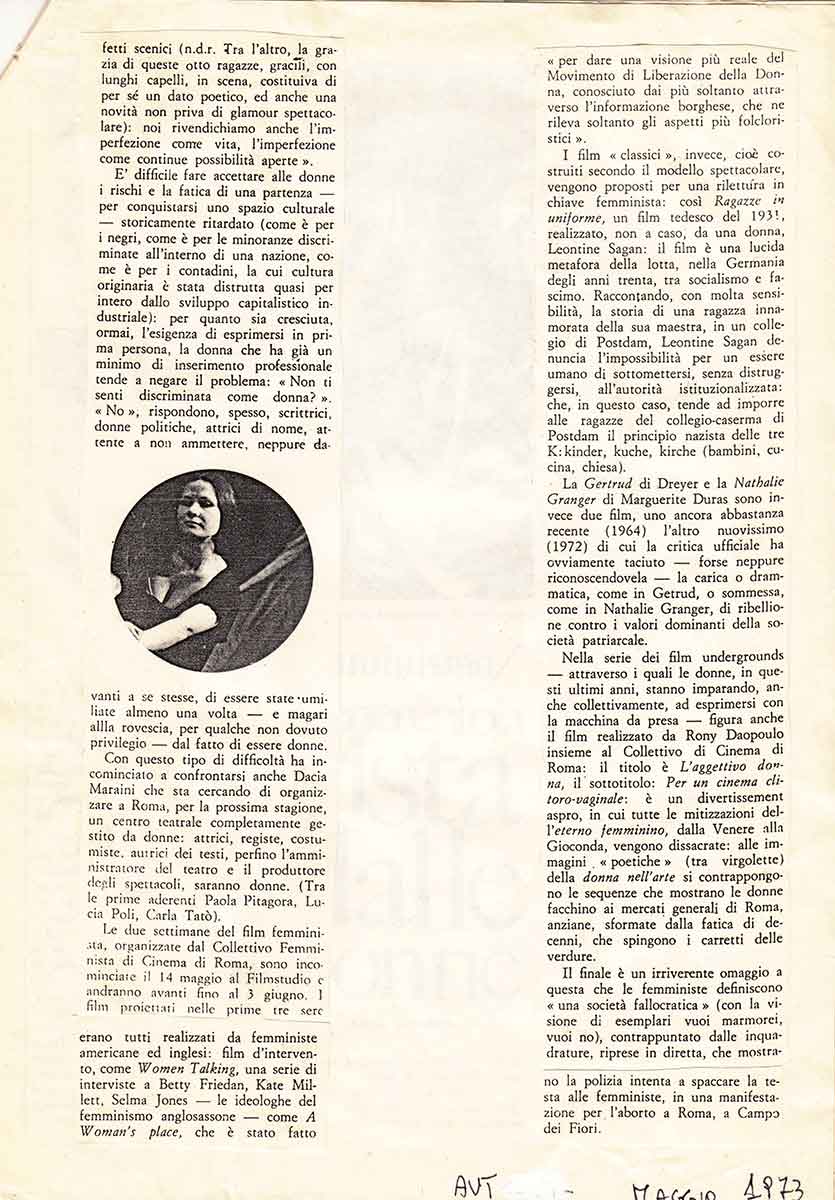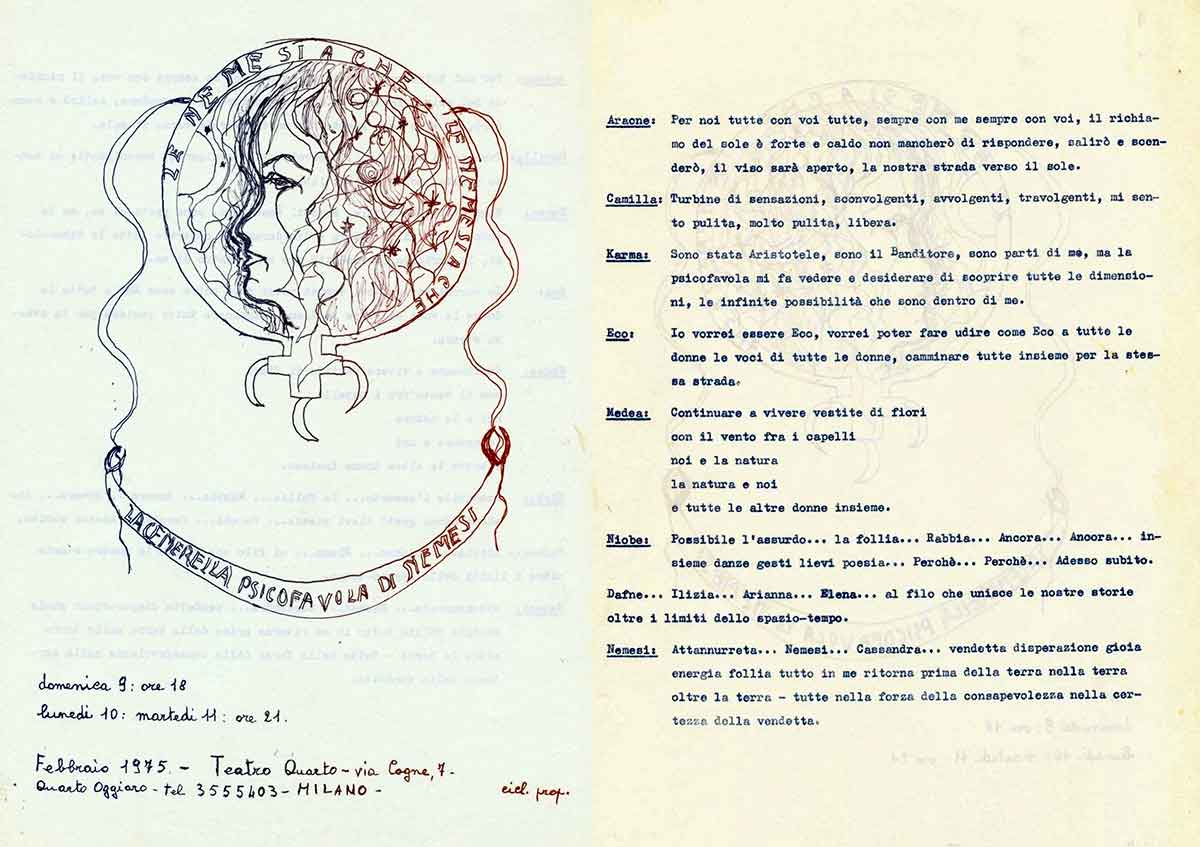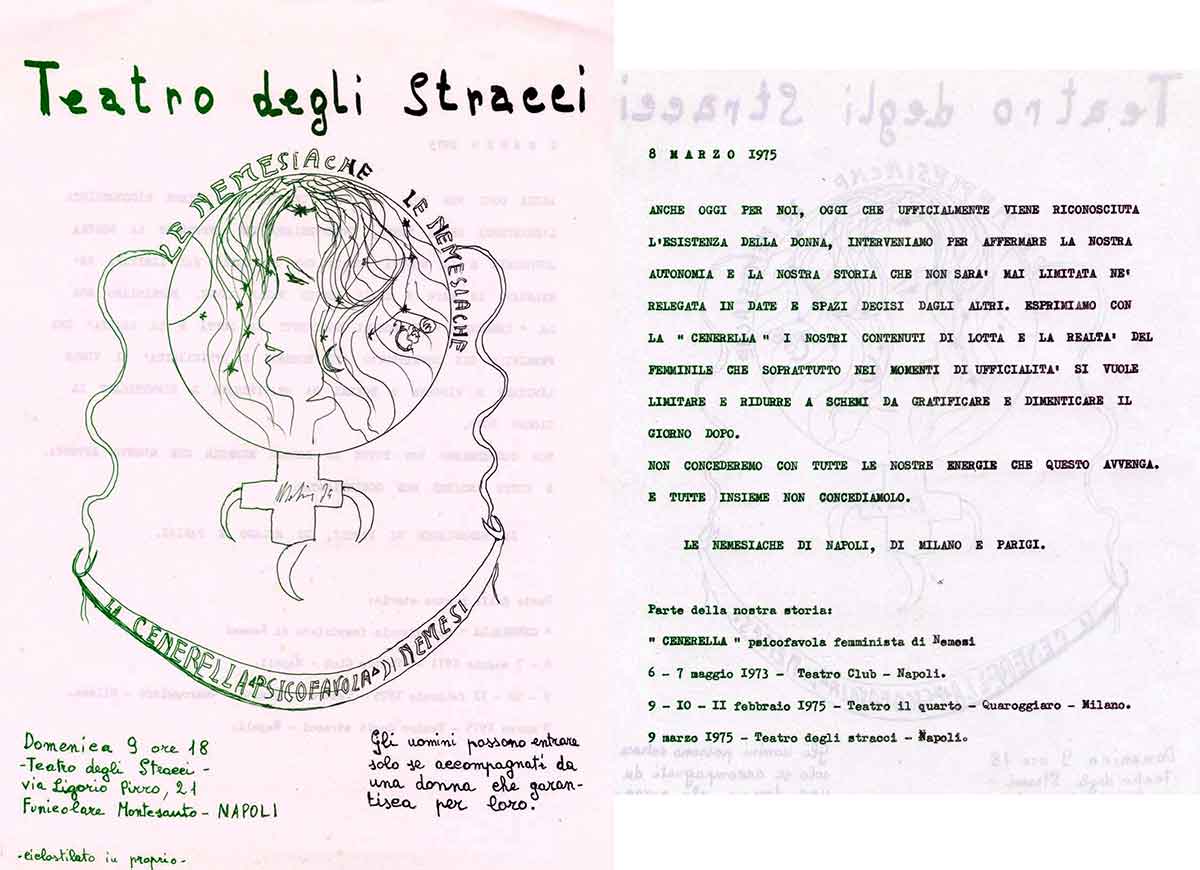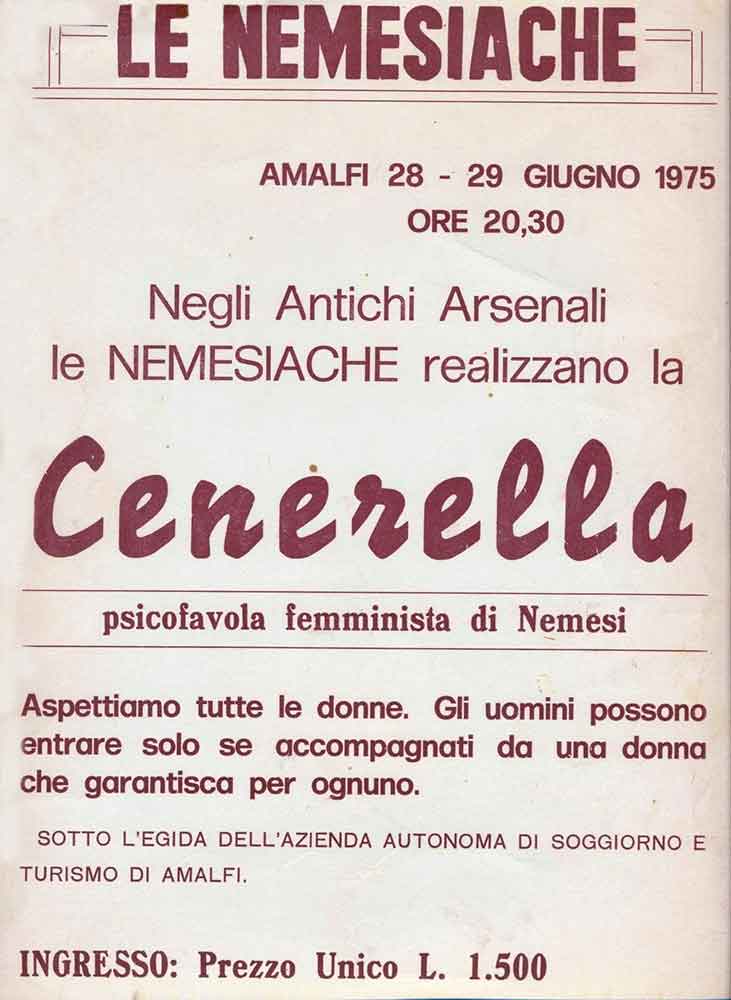Cenerella - Psicofavola
Soggetto Sceneggiatura Regia: Lina Mangiacapre
Musiche Originali: Nemesiache
Nazionalità: Italia
Durata: 90 minuti
Anno: 1973
Produzione: Cooperativa Le Tre Ghinee
E' la denuncia dell’oppressione di una donna – Cenerella -,
isolata fra tre uomini: il padre e i fratelli che rappresentano la
cultura maschile, ingannata dal mito dell’amore – il principe -.
La mancanza di conoscenza della storia di lotta e di morte delle
altre donne è la perdita della propria memoria storica,
personificata dalla Donna- Memoria. La scelta di legare all'uomo
il proprio destino è la perdita dei propri poteri di donna: magia,
alchimia, astrologia, del proprio corpo, ed è la perdita di
Attannurreta, la dimensione totale e autonoma del femminile.
Attannu e Arreta, termine della tradizione orale popolare
napoletana. Cenerella - Donna Memoria - Attannureta, sono una
stessa realtà divisa in tre aspetti che ritrovati e riuniti
conducono alla liberazione.
6 – 7 maggio 1973 - Teatro Club - Napoli
9 – 10- 11 febbraio 1975 Teatro il Quarto – Quarto Oggiaro –
Milano
9 marzo 1975 - Teatro degli Stracci – Napoli
29 -29 giugno 1975 Arsenali - Amalfi
Rassegna
Femminismo/ Cenerentola – Vista dalle donne
AUT – Maggio 1973 di Adele Cambria
Dicono:” Noi denunciamo, noi rigettiamo, noi rivendichiamo, noi ci
esprimiamo: con il teatro”. Dicono:” Sino ad ora la donna è stata
espressa dall’uomo e si è espressa tramite l’uomo che capitalizza
la sua creatività, le sue idee, il suo lavoro, le sue energie
vitali. Usiamo il cinema per vivere la nostra creatività, la
nostra fantasia, la nostra immaginazione. Perché questo ci
diverte”.
Due documenti femministi, il primo del gruppo napoletano “Le
Nemesiache”, l’altro del Collettivo Romano Femminista di Cinema,
parlano coraggiosamente a questo modo e, dando per scontati i
sarcasmi, centrano il problema dello spazio culturale che le donne
hanno bisogno di gestire, finalmente, in proprio, in prima
persona: muse, ispiratrici, ninfe egerie, male femmine o vipere,
le donne sono state quasi costantemente “viste” dagli altri (dagli
uomini) in ogni tipo di espressione o rappresentazione culturale,
dal poema omerico a quello scespiriano o dantesco, e ancora nella
pittura e nella statuaria, dalla iconografia etrusca a Moore, nel
teatro – da Euripide a Goldoni a Beckett – perfino nel cinema,, un
mezzo di creazione relativamente giovane. Le donne non creano,
sono create, inventate dagli altri secondo schemi che esprimono la
mentalità dominante (maschile): la donna, sia pure “protagonista”
di romanzi, poemi, spettacoli, ecc. si limita ad essere ciò che
l’uomo proietta su di lei: così l’inconscio maschile, cercando di
padroneggiare o addirittura di negare i concetti di natura, amore,
male, peccato ne fa delle attribuzioni della femminilità, li
trasferisce sopra la donna, inventa Circe ed Eva; ancora, il
desiderio maschile di dominio e possesso crea l’immagine della
donna passiva, sottomessa, impotente, da proteggere (Lucia
Mondella).
Così la repressione sessuale che l’uomo subisce, oggi, nella
famiglia ancora, culturalmente patriarcale,, nel lavoro,
attraverso la pornografia alimentata dal sistema, lo porta a
mitizzare la verginità, la purezza, la fedeltà: e se Dante
inventava Beatrice e Omero Penelope, la disponibilità sessuale
opaca ed avida di compensi della Cecilia moraviana non è che
l’ammissione di un fallimento maschile: la donna non-vergine è
vista, nonostante tutto, come un disvalore. Persino le fattezze
fisiche delle eroine, la loro esteriorità, è inventata dall’uomo,
secondo un canone estetico variabile, da un tempo all’altro, ma la
cui costante è la celebrazione del rapporto sadomasochistico: da
L’Angelo Azzurro a Ultimo tango a Parigi.
L’esigenza di dire di sé in prima persona, che più acutamente oggi
le donne sentono e si provano a soddisfare, con tentativi di
teatro, di cinema, anche di romanzi femministi, non rifiuta, al
contrario, gli apporti, in qualche modo miracolosi, che alcune
donne, nel corso della storia culturale dell’umanità, sono
riuscite a dare comunque: se ne tende anzi al recupero, partendo
dall’analisi, che deve essere estremamente lucida del livello di
autocoscienza (coscienza della propria condizione di donna) che
ciascuna ha espresso: per stabilire, cioè, fino a che punto siano
riuscite ad esprimersi come donne, e dove abbiano invece subito,
anche qui la colonizzazione maschile: in una tale analisi, Saffo
si opporrebbe evidentemente, a George Sand, che perfino nella
scelta del nom de plume, maschile, rifiutava, quasi con isteria
(ma avrebbe potuto dare diversamente?) la propria identità.
Né l’inevitabile (anche sana) rabbia sovversiva del femminismo può
rifiutarsi, nei tempi lunghi, di accogliere parole di uomini la
cui intuizione poetica abbia decifrato ed espresso l’identità
femminile: così Rimbaud: “Quando sarà spezzato l’infinito
servaggio della donna, quando ella vivrà di sé e per sé…sarà anche
lei poeta. I suoi mondi di idee differiranno dai nostri? Ella
troverà delle cose strane, insondabili, ripugnanti, deliziose: noi
le prenderemo, noi le comprenderemo”.
Strane, insondabili, ripugnanti, deliziose: sono tutti aggettivi
perfetti per descrivere, nella loro situazione di scena, le
ragazze di Napoli del gruppo “Le Nemesiache”.
Un seminterrato all’Arenella, la zona più popolare del Vomero, il
loro teatro: una lanterna rossa di carta sulla porta piccola: e
manifesti disegnati e colorati a mano, uno per uno, dicono il
titolo dello spettacolo: Cinerella, psicofavola, e segue
l’annuncio che a molti maschi (di malafede) appare provocatorio:
“esclusi gli uomini”.
L’operazione compiuta dalle ragazze napoletane è stata la
rilettura della favola classica di Cenerentola, cercando di
individuare e distruggere (piuttosto che rovesciare) la
“patriarcalità”: intanto, le due sorellastre cattive di
Cenerentola sono diventate uomini, cioè si denuncia la mentalità
sopraffattoria come tipicamente maschile: la sopraffazione
culturale è identificata con la maschera di Aristotile ( e magari
la schematizzazione può essere rozza). Cenerentola, “casalinga”,
ossessionata dal padre e dai due fratelli di cui è al totale
servizio, riesce a esistere “ in proprio” soltanto nel contatto
vitale, arcaico che mantiene con la natura (quest’idea della
primitività misteriosa e sacra della donna, come di terra-madre, è
rifiutata da gran parte delle femministe, che nell’identificazione
donna-natura temono di vedersi contrapporre, ribadito, il dominio
razionale dell’uomo).
I luoghi e i personaggi classici della favola – il bando che
annuncia il ballo al castello, il principe che cerca moglie – sono
rappresentati buffonescamente, con gentile sarcasmo: anche
Cenerentola cede alla mistificazione (matrimonio eguale felicità)
per il suo bisogno d’amore, e una fata madrina di estrazione
mitologica, Attannarruta, l’ammonisce sui rischi che corre: “Per
me sei bellissima come sei, con questa tunica di cenere, ma poiché
gli uomini non ti vedrebbero, poiché nessun uomo è capace di
vederci davvero, ti vestirò di stelle…”.
Cenerentola si sposa (il padre stende un regolare contratto di
vendita col principe), ma la favola non finisce: lui parte
lasciandola incinta per una guerra che è, insieme,
rappresentazione del bisogno di violenza dell’uomo e della sua
competitività: una guerra che può essere una carriera politica o
di manager, un traguardo scientifico o la conquista dell’Everest,
o del grado di capufficio, tutte mete, comunque, da cui la
donna-moglie è esclusa: “E mi conforterà il saperti – proclama il
principe – al sicuro nella mia casa, al sicuro con mio figlio”.
Che poi appena nasce glielo toglie, “perché cresca uomo tra gli
uomini”, sottratto alle carezze femminili che l’infiaccherebbero,
sapiente e non ignorante come sua madre; come le donne.
Può sembrare a qualcuno elementare questa rilettura della favola,
come l’hanno data “ le Nemesiache” a Napoli, la settimana scorsa
(l’occasione polemica era la celebrazione della festa della Mamma,
fissata dal calendario dei consumi al 13 maggio): e quanto le
donne siano ancora condizionate dal rispetto e per l’opinione
pubblica, che è poi l’opinione dominante, cioè maschile, lo si è
visto nel teatrino dell’Arenella: la elementarità della
rappresentazione, ispirata tuttavia ad un modello preciso, il coro
greco, la povertà delle luci, dei vestiti, l’inesistenza
dell’addobbo scenico, la fatica e l’emozione che rompevano le voci
delle ragazze, sono sembrate anche ad alcune femministe, tra il
pubblico, come segni di una imperfezione dello spettacolo che
doveva a tutti i costi essere nascosta: eppure Lina, la leader
delle Nemesiache (ma le femministe non riconoscono, tra loro,
leaders) l’aveva detto, ad apertura dello spettacolo: “Noi
rigettiamo qualunque discorso tecnico e scientifico come valido:
rivendichiamo la forza dei contenuti, che non ha bisogno di
effetti scenici (n.d.r. Tra l’altro, la grazia di queste otto
ragazze, gracili, con lunghi capelli, in scena, costituiva di per
sé un dato poetico, ed anche una novità non priva di glamour
spettacolare): noi rivendichiamo anche l’imperfezione come
continue possibilità aperte”.